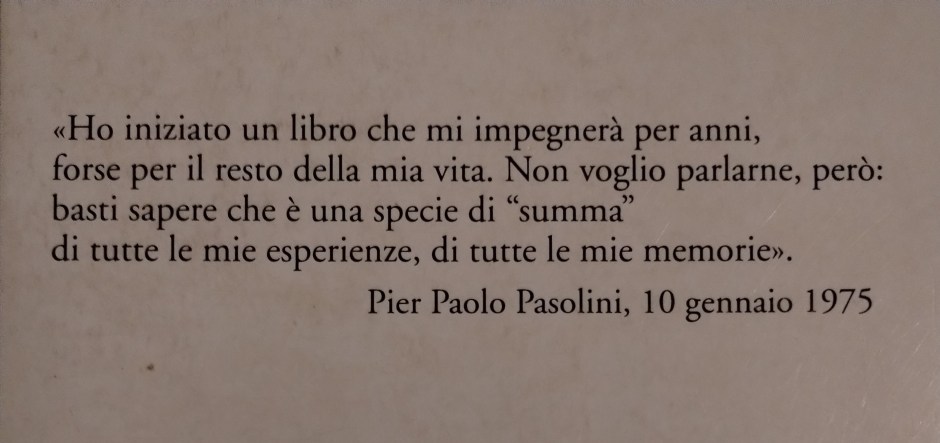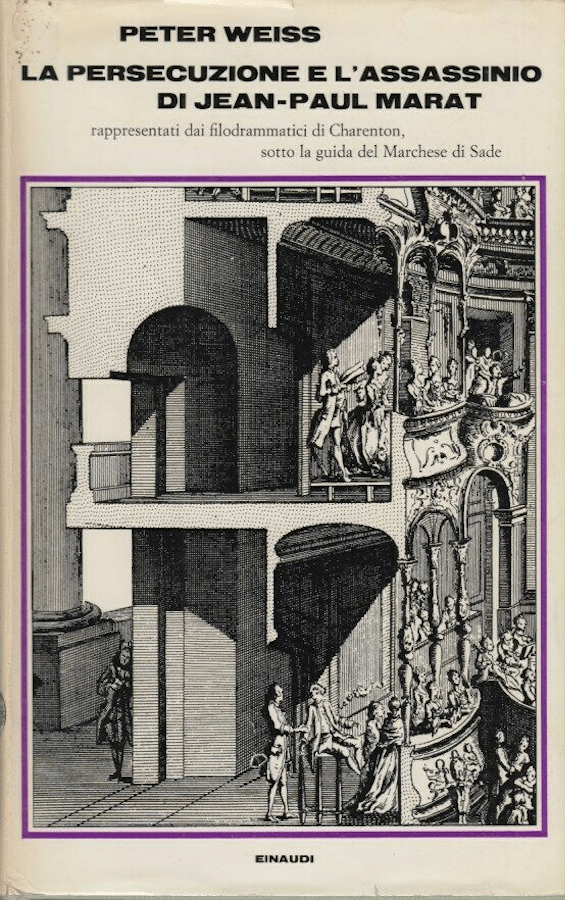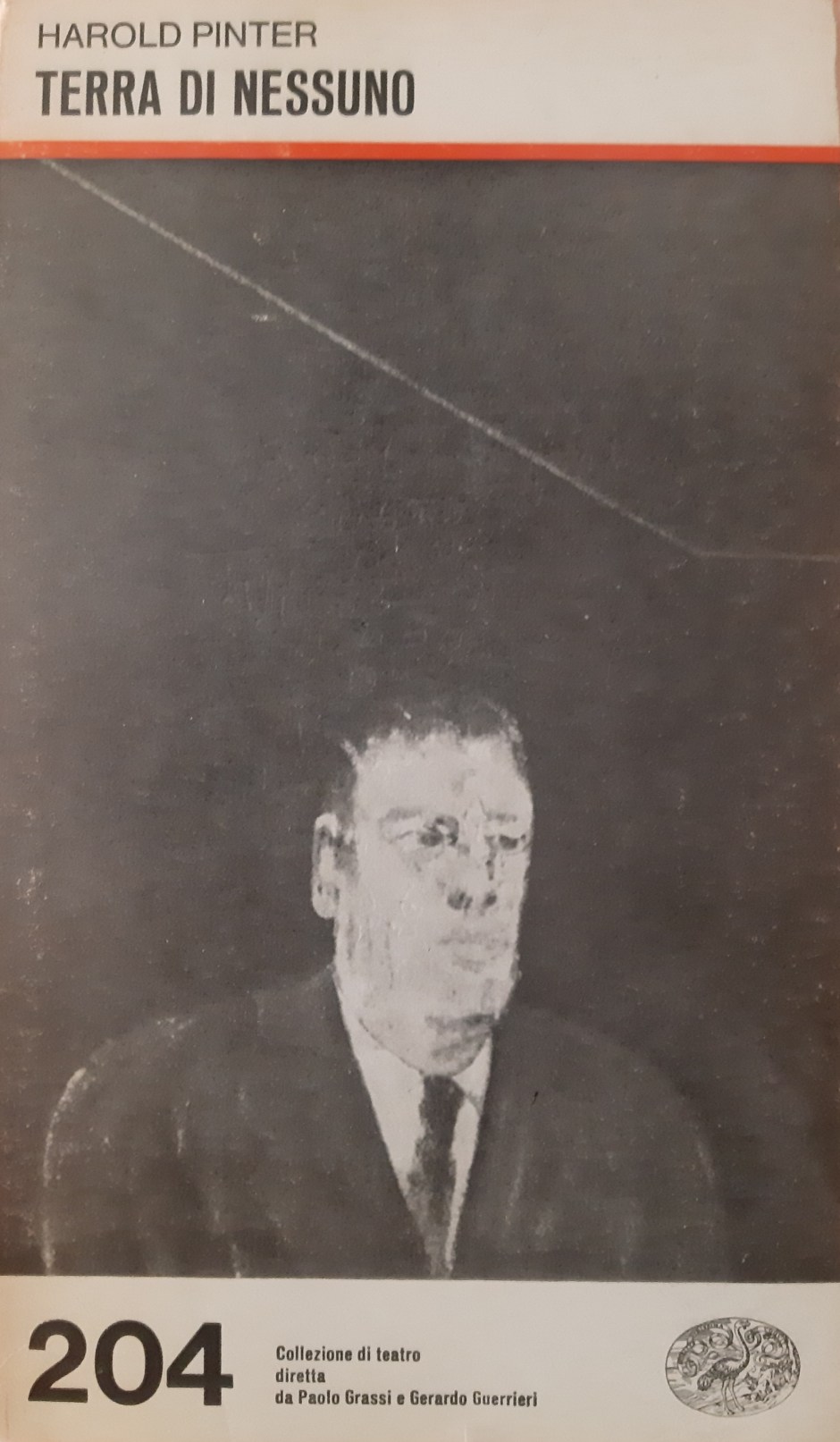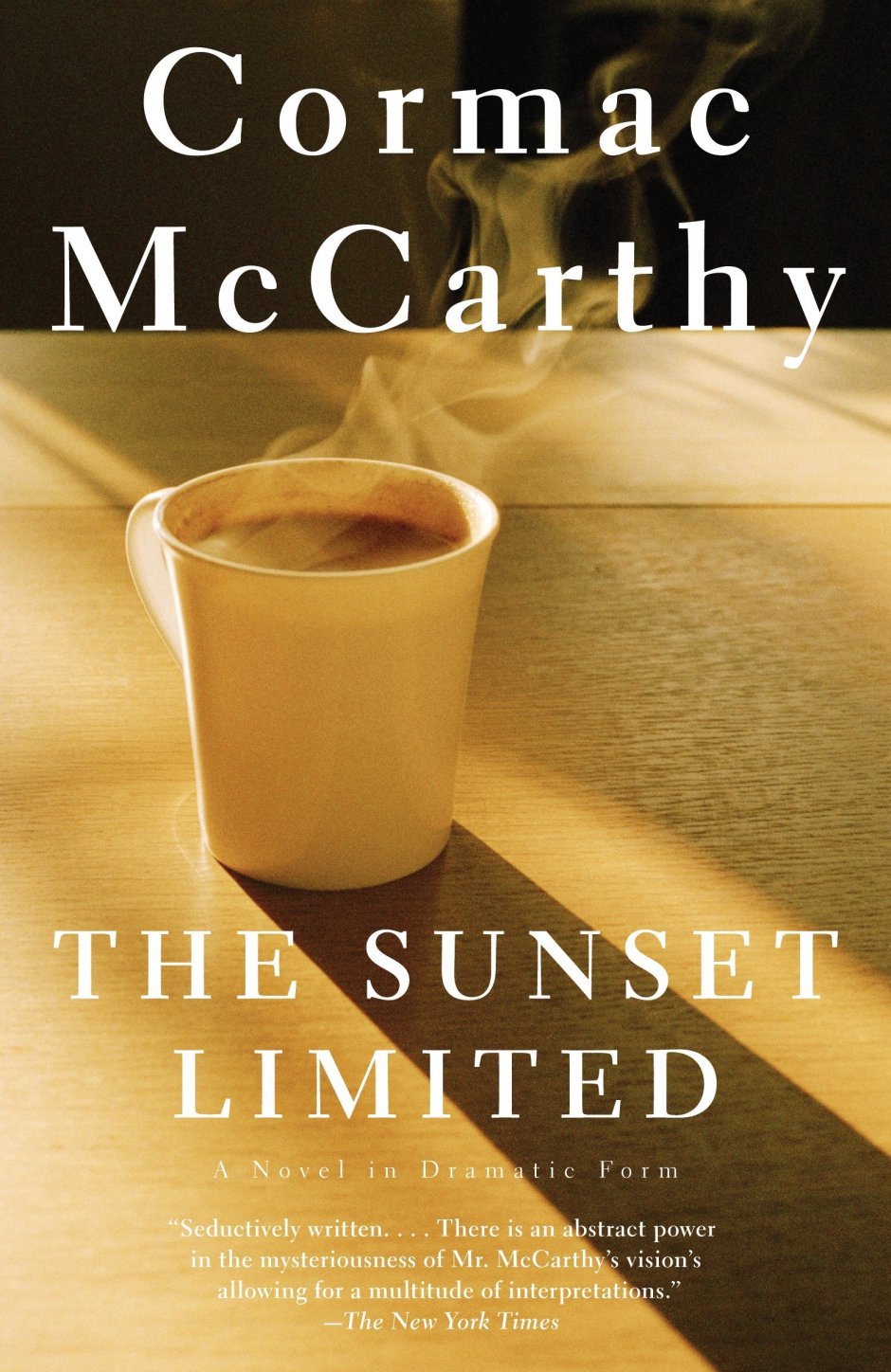Non c’è niente di più comico dell’infelicità, […] Sì, sì, è la cosa più comica che ci sia al mondo. [Nell in Endgame, 1957]
Nel mese di giugno del 2024, su invito dell’Associazione Libero Sé, ho tenuto un seminario residenziale di tre giorni sul teatro di Samuel Beckett. Si è trattato di un intervento didattico centrato sull’interpretazione dei testi e dei personaggi, rivolto quindi ad attori e registi teatrali, e a chiunque, non necessariamente “teatrante”, avesse voluto approfondire la produzione del drammaturgo dublinese.
Già in una prima fase di studio e preparazione, l’argomento si è mostrato di una vastità tale da costringermi a uno sforzo non banale di sintesi e comunicazione. Trovare un buon titolo è stato relativamente semplice: erano diverse settimane che il tennis italiano, trainato da Jannik Sinner, scalava le classifiche internazionali accendendo interesse e fantasie dei tifosi, e mi è sembrato perfetto a tal fine l’intercalare utilizzato dal personaggio di Lucky nel suo monologo in Aspettando Godot: “malgrado il tennis”. Più complicato il sottotitolo, formula che tradizionalmente racchiude in breve l’indicazione sull’oggetto e sul taglio dell’intervento didattico. La scelta è caduta su “degrado e marcescenza nei personaggi del teatro di Samuel Beckett”. Perché appunto il degrado e la marcescenza (ho utilizzato i due termini praticamente come endiadi, rafforzandone così il significato) mi sono sempre parsi la colonna portante dell’edificio beckettiano.

Il primo punto che mi è sembrato corretto trasmettere ai partecipanti, è che di fronte a un autore di così alto spessore intellettuale non è indispensabile una conoscenza altrettanto intellettuale. Quest’ultima (che lungi da me voler banalizzare o minimizzare) rischia di mettere in soggezione e scoraggiare l’approssimarsi all’autore che, ripeto, perlomeno nel caso di Beckett, è produttivo anche se resta sulla superficie. Mi spiego: si può conoscere (ad esempio) Hieronymus Bosch o Bruegel il Vecchio senza necessariamente disporre di strumenti storico-critici sulla storia dell’arte o sul rinascimento fiammingo e olandese. Si possono conoscere o, ancor meglio, si possono riconoscere (sentirli o meno nostri) i loro immaginari che hanno visivamente – e icasticamente – segnato, scolpito, caratterizzato tutta la loro produzione pittorica: i visi dei loro personaggi, le loro posture, espressioni, gestualità, le situazioni in cui vengono ritratti, i temi iconografici ricorrenti. E non inserisco casualmente Bruegel il Vecchio in questo discorso: il suo è un grottesco che ha molti tratti comuni con quello beckettiano, sorta di proto espressionismo che staziona sul crinale tra tragico e comico, grottesco in un contesto comunque realistico, ma un realismo dai contenuti che rimandano al povero e all’antico, al brutto, animalesco, sporco.
Intendo dire che conoscere Beckett è qualcosa che non necessariamente contempla il capirlo o destratificarlo nel profondo: c’è uno strato superficiale di Beckett, una sua “pelle”, un viso, una geografia, un territorio talmente ricco, logorroico di immagini e visioni e segni ricorrenti, reiterati, evidenziati, che “capire” appare quasi un’inutile distrazione rispetto al “conoscere”. A tale proposito c’è un passaggio molto eloquente in Giorni Felici (Happy Days, 1961), nel racconto della coppia di viaggiatori che si sofferma davanti a Winnie, semi sepolta dalla duna: Che significa?, chiede più volte lui, quasi stizzito da quell’immagine insensata che non sa capire; Perché, tu cosa significhi?, gli risponde la moglie.
Questo approccio che ho proposto per Beckett potrebbe sì valere per qualsiasi altro artista, ma in particolare mi sembra efficace per chi si esprime attraverso un uso privilegiato dell’immagine. Beckett è un drammaturgo (oltre, ovviamente, che romanziere, ma in questa sede ci interessa soprattutto come drammaturgo), quindi uno scrittore, ma il suo teatro, pur indubitabilmente “di parola”, passa sempre attraverso l’uso di elementi di rara potenza visiva, simboli e allegorie veicolati attraverso soluzioni sceniche e registiche forti che coinvolgono vista e udito, immagine e suono: l’albero di Godot, la duna di Winnie, la bocca di Non Io, la sedia a rotelle di Hamm, le giare di Commedia, i bidoni di Nag e Nell, il magnetofono di Krapp, il primo piano di Joe. E poi i personaggi, così grotteschi, esagerati, coloriti nel loro grigiore esistenziale, buffi e infernali, degradati nel senso di spogliati, ridotti all’osso, marcescenti perché la vita li ha resi marci, personaggi predittivi, portatori di una profezia che ci riguarda. Infine i temi, stilistici, narrativi, drammaturgici, formali e contenutistici, così netti, riconoscibili, usati dal Nostro con una progettualità quasi ingegneristica.
Vediamo il tutto più da vicino.

I RICORDI E IL RIMORSO, IL TEMPO, L’ATTESA, LA SPIRALE
Molti personaggi beckettiani sono consumati dal ricordo e dal rimorso. La stasi del presente (spesso evidenziata dalla loro immobilità fisica) è bilanciata dalla presenza di un agitato ricordo del passato. Ciò che muove le loro giornate è il passato, la vita che non c’è più, non il presente; ma il passato in Beckett non possiede le solari aperture proustiane, semmai è il movimento di una punta di coltello che rimesta la carne viva di una ferita mai chiusa. L’ultimo nastro di Krapp (Krapp’s Last Tape, 1958), è esemplare in questo senso. Si tratta del testo teatrale più straziante di Beckett, probabilmente perché tra i 4 suoi maggiori drammi è quello che immediatamente tocca – e tocca forte – sensibilità e stati d’animo che ognuno conosce, o che prima o poi conoscerà lungo l’accidentato percorso della propria vita. Non che gli altri testi siano all’insegna della leggerezza ma, ad esempio, Aspettando Godot si riscatta per le sue meravigliose acrobazie linguistiche, la cura musicale dei dialoghi, il carattere evocativo della scenografia; Finale di Partita si riscatta grazie all’uso del grottesco e dell’iperbole che svela le potenzialità comiche di un testo altrimenti sepolto dalla cupezza postapocalittica; infine Giorni Felici mi sembra il momento beckettiano più vicino al cinismo ironicamente disincantato e buffo di Ionesco. Krapp non ha nulla di tutto questo, è il nadir della Recherche proustiana, rappresenta il giungere al tramonto della propria esperienza terrena, guardarsi alle spalle e scoprire il proprio tempo perduto come ostinata ricerca e costruzione del fallimento, il fallimento elevato a sostanza esistenziale, il fallimento come giudizio su sé retrospettivo e stratificato, che si ripete in progressione frattale: Krapp che riascolta e disprezza il Krapp di trent’anni prima che ascoltava e disprezzava il Krapp di dodici anni prima. Il giudizio senza appello è sul Krapp che amava e scriveva. L’insensatezza dell’amore e la ridicola inutilità della letteratura sono i due temi intorno cui Krapp, attraverso il ricordo, costruisce la montagnola della disillusione che l’ha seppellito (che rimanda al mucchio di Clov in Finale di Partita e al monticello di Winnie in Giorni Felici), l’altare sacro dove rende sarcastico culto al proprio fallimento tronfio e superbo.
Qui termino questo nastro. Scatola… tre, bobina… cinque. Forse i miei anni migliori sono finiti. Quando la felicità era forse ancora possibile. Ma non li rivorrei indietro. Non col fuoco che sento in me ora. No, non li rivorrei indietro. [Krapp in Krapp’s Last Tape, 1958]
Non meno ricco di significati è il primo piano straziato di Joe (Eh Joe, dramma per la televisione, 1965) mentre la sua testa è colonizzata da una voce femminile che gli elenca i peccati con cui ha costellato la volta celeste della propria esistenza: narcisismo, egoismo, superficialità, mancanza di empatia e infine istigazione al suicidio. (Questo testo di circa venti minuti fu scritto per la televisione e prevede il progressivo avvicinamento della cinepresa verso il viso di Joe fino a un dettagliatissimo primo piano della sua espressione sofferente. Riportato in ambito teatrale e laboratoriale, ho sostituito i movimenti della telecamera con l’avvicinarsi, per successivi step, del pubblico al viso dell’attore, fino a una distanza, nell’ultima scena, di una ventina di centimetri).
Ed è ancora la voce dei ricordi proveniente da tre differenti direzioni – e da tre diversi momenti della sua vita – ad aggredire la testa immobile del vecchio ascoltatore (Vecchia faccia bianca, lunghi capelli bianchi sparpagliati) in That Time (Quella Volta, 1975). Nonché tutto Finale di Partita (Endgame, 1957) si gioca su una continua riesumazione sadomasochista dei ricordi, da quelli patetici – e cinicamente comici – dei due genitori, Nagg e Nell, costretti nei bidoni della spazzatura, a quello sadico del carnefice Hamm che stuzzica la rabbia di Clov inducendolo a fantasticare un progetto di fuga che mai si avvererà.

Anche il romanzo Molloy (1951) non sfugge a questa necrosi del tempo: quel poco di movimento che può permettersi Molloy, e che dà la direzione alle sue giornate, è verso la vecchia madre con cui ha “una questione in sospeso”. Non è dato sapere di che natura sia la questione, ma a pensarci bene cosa ci può essere di radicalmente in sospeso tra un uomo e sua madre se non il senso e il motivo della sua nascita? Echeggiano in questa direzione le parole di Hamm, quando si rivolge al padre chiedendo Maiale, perché mi hai fatto? Splendida, ironica, moderna la sua risposta: Non potevo sapere che saresti stato tu. In sostanza nei testi di Beckett il presente è solo un torbido riflesso dell’immodificabile passato, e nulla può davvero muoversi nella quotidianità dei personaggi, perché tutti zavorrati nei loro movimenti – e nel movimento narrativo – da un passato pesante, pervasivo e cementificato.
Fa singolare – ma solo parziale – eccezione Aspettando Godot (Waiting for Godot, 1952). Eccezione perché il ricordo sembra quasi assente nei 5 personaggi della pièce, prigionieri semmai di una serie infinita di “giorni della marmotta” dove la ripetizione schiaccia il fluire del tempo annullando qualunque differenza tra passato e presente. Il risultato drammaturgico non cambia: Vladimiro e Estragone, per certi versi i personaggi più leggeri del cupo universo beckettiano, se pur liberi dal fardello dei ricordi e del passato non sfuggono alle sabbie (im)mobili di una stasi priva di sbocchi.
Ecco che il tempo e il ritmo della narrazione assumono una forma simbolica (e matematica) molto chiara: la spirale. Mentre cerca ramingo la madre, Molloy si rende conto di girare intorno allo stesso punto e nel farlo perde progressivamente la mobilità. Il tempo beckettiano unisce la circolarità dell’eterno ritorno alla concezione lineare della storia: la spirale dà ragione a entrambe le concezioni, gira, ritorna, ma al tempo stesso procede, seppur lentamente, addirittura impercettibilmente, in modalità centripeta verso la fine, verso il buco nero del non ritorno. Altrettanto vale per le ripetizioni dei giorni e delle vicende in Godot, o per le stanche e sempre uguali mosse nella statica partita tra Hamm e Clov. Le variazioni sono minimali, tutto sembra ripetersi nell’inerme abitudine e nell’attesa di quando finalmente smetterà.

Teatro tragico, teatro dell’attesa, della ripetizione, dell’impossibilità ontologica di fare e addirittura di dire. Un teatro che non dirige una riflessione, semmai che disegna con tratto deciso una conclusione sul (non)senso della vita e dell’esistenza: Ormai siete al mondo, non c’è più rimedio!, urla Hamm in Endgame.
E infine questo procedere ciclico e centripeto del tempo, e dunque del tempo della narrazione, produce una personalità e riconoscibilità musicale del teatro beckettiano, che è indolente ma ipnotico, avvolgente, dotato di una partitura drammaturgica priva di picchi ritmici eppure mai lasciata a se stessa, sempre saldamente sotto controllo, spesso ancorata su un tema verbale ricorrente che si propone, viene elaborato, si propone di nuovo ma con lievi variazioni (-Andiamocene. –Non si può. –Perché? –Aspettiamo Godot. –Già, è vero).
IMMOBILITÀ E CECITÀ
Il teatro di Beckett azzera l’operatività dell’uomo nei confronti della vita. Il passato, come già detto, blocca il presente; l’atto stesso di nascere, darsi alla luce, è quel trauma, o colpa, del passato che impedisce il dinamismo del presente. Ma la stasi è ulteriormente evidenziata dal degrado fisico che lo scorrere del tempo ineluttabilmente opera. Molti personaggi beckettiani sono immobili, e tanti altri ciechi. È immobile Winnie in Giorni Felici; Hamm, Nag e Nell in Finale di Partita; A, B, C in Commedia; Bocca in Non Io; è immobile, seduto in pizzo al letto Joe; ed è progressivamente immobile Molloy, che si ridurrà a rotolare su sé stesso per muoversi alla ricerca della madre. Infine è immobile il Malone di Malone Muore (1951), che più di tutti, con la sua immobilità, preannuncia la propria morte. E poi è cieco Hamm; lo diventa Pozzo nel secondo atto di Godot; c’è la cecità di Dan Rooney nel radiodramma Tutti Quelli che Cadono. Tutti questi personaggi perdono ogni capacità di “fare”: l’homo faber, e il mito capitalistico esistenziale della produzione, si fanno da parte di fronte all’impotenza a cui la vita ci obbliga. In tutti questi derelitti convive un senso di astrattezza – un non essere più calati nelle vicende della vita, o forse non esserlo mai stati – e al tempo stesso un nucleo profondo, nascosto, permanente, inalterabile, di verità esistenziale che coincide con la morte, come se Beckett per sottrazione e progressiva spoliazione (di vita) mostri, come avviene in una lastra radiografica, la vera struttura dello stare nel mondo, e si tratta ovviamente di una struttura scheletrica. I personaggi beckettiani sono scheletri in vita e il ghignare di Hamm e Clov è, appunto, quello tipico dello scheletro.

Ma l’immobilità dei personaggi beckettiani lavora anche su un secondo versante, antinaturalistico fino allo smembramento stesso del personaggio, quello della finzione teatrale quanto quello della realtà. In questo senso va citata Commedia (Play, 1963), uno dei testi teatrali più estremi di Samuel Beckett, si potrebbe definire il suo testo più brechtiano, non nelle soluzioni drammaturgiche o sceniche che ovviamente divergono dall’autore tedesco, ma nello spirito, nelle finalità, sì. Commedia prende una situazione tipica del dramma borghese – un triangolo sentimentale tra un uomo e due donne – e la scompone, la viviseziona, la smonta mostrandone i singoli pezzi, la loro funzione, il meccanismo complessivo. Non solo il contenuto esistenziale sotteso all’evento drammatico, contenuto tipicamente beckettiano: la ripetizione, l’assenza di sostanziali cambiamenti, la recitazione di ruoli prefissati; in Commedia, Beckett svela sottilmente la distinzione tra essere il ruolo che si interpreta e essere colui che attraverso il linguaggio si fa carico del ruolo che si interpreta, una distinzione più radicale di quella pirandelliana, che va ben oltre il contesto teatrale per abbracciare quello esistenziale: non c’è nulla oltre il proprio ruolo. Ed è geniale la soluzione adottata – molto oltre Brecht – per rappresentare questa svestizione radicale e irriguardosa: il dialogo nervoso tra il personaggio e il riflettore che lo illumina, e che illuminando lo interroga senza pietà. Commedia si rivela il ponte tra due temi “forti” della riflessione esistenziale e antropologica beckettiana: l’immobilità – il nucleo dell’uomo – e il linguaggio – il suo vestito.

L’ERUZIONE INCONTROLLATA DEL LINGUAGGIO
Parlavo sopra di un teatro che esprime l’impossibile di fare e di dire. In un dato momento del primo atto di Aspettando Godot, quell’assurdo personaggio che è Lucky, muto, passivo, schiavizzato e inebetito, inizia a parlare. Un torrente di parole gli esce dalla bocca, un’eruzione linguistica fuori controllo e apparentemente senza senso, di certo un parlare, il suo, slegato dal contesto e privo di una chiara funzione di significazione, enunciativa o informativa. L’impressione è quella di un uomo posseduto. Da cosa? Da quale demone? Posseduto dal linguaggio. Anche in Not I (Non Io, 1972) Beckett gioca con l’alternanza afasia logorrea espressa visivamente attraverso la separazione fisica della bocca dal resto del personaggio (Non io, dice Bocca, lei!). La donna, di cui Bocca è sineddoche, racconta di una vita immersa nell’assoluto mutismo interrotto solo una o due volte l’anno, generalmente in inverno, quando il linguaggio improvvisamente sgorgava fuori impetuoso e sconclusionato. Il linguaggio (altrui) infastidisce anche il logorroico Hamm: Ma di che cosa trovano modo di parlare, di che cosa c’è ancora modo di parlare?
Infine un significativo passo dal romanzo Molloy, dove il vagabondo si esprime sulle parole in questi termini: Sì, le parole che sentivo, e le sentivo benissimo, avendo l’orecchio abbastanza fine, le sentivo la prima volta, e anche la seconda, e spesso anche la terza, come dei puri suoni, liberi da ogni significato… [Molloy, Einaudi 1996, pg. 52]
Paradossale che un teatro di parola come questo si adoperi per svuotare di senso la parola, soprattutto la frase borghese. Ma attenzione, in Beckett non c’è una vaga e generica morte del linguaggio e/o della sua facoltà narrativa, semmai il funerale celebrato riguarda la sua capacità redentiva.
La riflessione sulle valenze inesplorate del linguaggio attraversa la storia della drammaturgia moderna probabilmente a partire dal famoso incipit dell’Ubu Roi di Jarry, “Merdre”, e trova la massima focalizzazione in quel gruppo di autori teatrali attivi già nell’immediato dopoguerra e che il critico Martin Esslin avrebbe catalogato all’interno di un genere omogeneo definito “Teatro dell’Assurdo”. Pochissimi anni prima di Lucky va in scena una delle più famose pièce di Ionesco, La Cantatrice Calva, dove si mostra con evidenza una consistenza ontologica del linguaggio come fenomeno staccato dall’individuo, preesistente all’individuo, dotato di vita propria, un linguaggio dalle fattezze storiche e sociali che sovrasta l’individuo come un vento impetuoso e come il vento dall’individuo può essere imbrigliato e sfruttato, a volte per grandi architetture verbali e molte altre (il più dei casi) per banali costruzioni, quasi mai per comunicare davvero. Beckett condivide con Ionesco, e con lo spirito dell’epoca, la fascinazione per un’analisi e utilizzo letterario non conforme del linguaggio, ma la sua è un’operazione – o, meglio, una sperimentazione – formale più che intellettuale: un po’ come nell’intuizione delle avanguardie pittoriche, o nelle successive ricerche dell’espressionismo astratto, dove il colore abbandona il riferimento a un soggetto per farsi soggetto esso stesso, Beckett in alcuni momenti stacca la parola da qualsiasi referente – o in alcuni casi la lega a referenti depistanti – e la “lancia” sulla tela bianca del testo mischiandola ad altre, quasi facendola gocciare. Quello di Lucky è l’equivalente linguistico del dripping di Pollock. Anni dopo, in Terra di Nessuno, Harold Pinter costruirà un ponte tra Ionesco e Beckett inscenando larve umane sorrette in piedi esclusivamente da un eccesso grottesco di verbalizzazione.
Un linguaggio che smette di descrivere, spiegare, dirigere un’azione, si lega alla scomparsa stessa dell’azione: il suo teatro, ma direi anche la sua narrativa, la Trilogia in particolare, è impossibilità di azione fisica, ovvero stasi, assenza di movimento, o progressiva tendenza alla stasi: i personaggi non si muovono e il loro linguaggio si disarticola.

MARCESCENZA, DEGRADO, VAGABONDAGGIO, STUPORE E INNOCENZA
È nella tranquillità della decomposizione che ricordo quella lunga emozione confusa che fu la mia vita, e la giudico, come sta scritto che Dio giudicherà noi, e con altrettanta impertinenza. Decomporsi è ancora vivere, lo so, lo so, non tormentatemi, non si può essere sempre tutti d’un pezzo. [Molloy, Einaudi 1996, pg. 25]
Torsi umani, consumati dai ricordi di Quando la felicità era forse ancora possibile [Krapp’s Last Tape], inabili al fare, al muoversi, al vedere, inermi di fronte al lento scorrere del tempo, i personaggi di Beckett marciscono e si decompongono, fisicamente e moralmente, rifiuti tra i rifiuti, o dentro bidoni dell’immondizia, scarti di un qualcosa (la società?) che nemmeno viene rappresentato, vagabondi come se non ci fosse vera alternativa a esserlo. Eppure il suo non è mai un teatro di denuncia politica, non c’è dietro alcuna ideologia o analisi sociale, né la descrizione di psicologie individuali: i derelitti di Beckett sono nuclei disvelati che mostrano con disarmante realismo la miseria esistenziale della condizione umana, un abbrutimento fatto di egoismo privo di alternative, calcolo, disillusione, ipocrisia, grettezza, paure, condanne, relazioni tra aguzzini e schiavi. Sentimenti, immaginari e stati d’animo, che scolpiscono i visi, le posture, le voci dei personaggi e di chi li interpreta. Tutto è molto esagerato e grottesco, sulla linea introdotta da Jarry, e poi dalle avanguardie e infine da Ionesco, un grottesco che sconfina necessariamente nel metateatrale e antinaturalistico, con ampi prestiti dal varietà e dal cinema muto. E il dare confidenza alla maschera e all’allegoria non rinnega né offusca il realismo dei personaggi e la loro evidente riconoscibilità. Marcescenza e degrado scolpiscono i personaggi di Beckett avvalendosi di un realismo vivido che scandaglia e rispecchia con beffarda evidenza le nostre parti meno nobili.

E come svela il pensiero succitato di Molloy, marcescenza e decomposizione si possono anche legare a tranquillità, pacificazione, accettazione di qualcosa che, per quanto terribile, risulta naturale (Qualcosa sta seguendo il suo corso, dice Clov in Endgame). Come già Molloy stesso, anche i due vagabondi di Godot, Vladimiro ed Estragone, conservano uno sguardo sul mondo che è innocente, incorrotto, puro e candido, lo sguardo inerme di chi non ha niente e di chi non ambisce a nulla che non sia semplicemente un pasto caldo e un giaciglio per la notte (obiettivo che Molloy raggiunge ma da cui in seguito fugge). È un candore, il loro, riconducibile a quello dei clown – sono, di fatto, una coppia di pagliacci la cui relazione comica è vicina a quella tradizionale tra il Bianco e l’Augusto -, una lettura della vita fatta di stupore e ingenuità, come fossero bambini ignari delle verità socialmente consolidate e delle corrette regole di comportamento, immersi in un mondo a loro così incomprensibile da non suscitare nemmeno le giuste domande. Umani che non hanno mai abbracciato il peccato di hybris (di cui invece si macchia Pozzo, punito nel secondo atto di Godot con la cecità).
Questa rappresentazione “alla radice” dell’umanità, tanto genuina e incolpevole nel mostrare le sue istintive bruttezze, comiche meschinità e tenere debolezze, fa dell’immaginario beckettiano, del suo teatro e dei suoi personaggi, in sintesi del suo sguardo autoriale, qualcosa di sorprendentemente e amabilmente infantile.