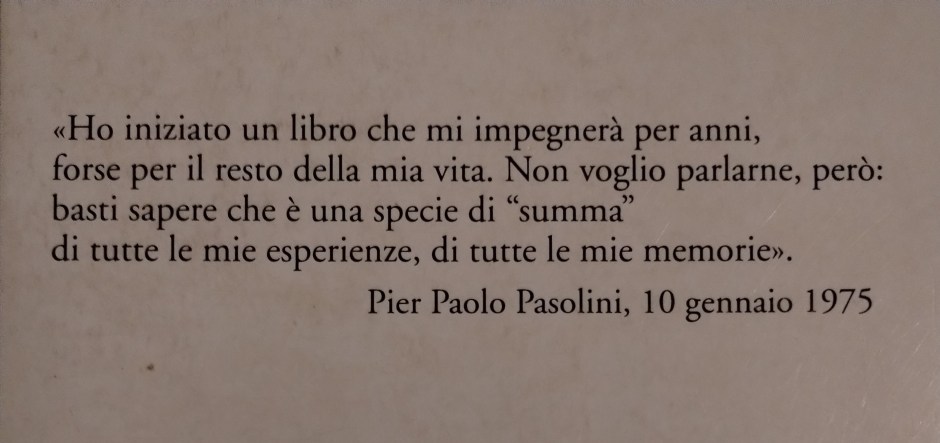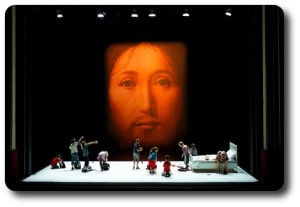UNA DEGRADANTE ANSIA INTERCLASSISTA – due momenti di degrado in PETROLIO di Pier Paolo Pasolini
«…nella sua faccia era impresso come un sorriso, deformante e continuo, di chi essendosi perduto o degradato è innocuo. Però quell’uomo stava morendo.» (Appunto 103).
Iniziamo con l’esposizione del metro, misurante e misurato: degrado, sostantivo maschile, derivato da degradare, graduale passaggio da una condizione migliore a una peggiore; degrado ambientale, decadenza, decadimento, degradazione, deterioramento, scadimento. Questo dice il sito della Treccani.
Nel dizionario di Repubblica, l’uso di degrado è in ambito ambientale e sociale: deterioramento subìto da determinati contesti sociali, urbani e ambientali per cause socio-economiche: il degrado del centro storico; il degrado urbano; il degrado delle coste; vivere in condizioni di degrado.
Il De Mauro è più stringato ma introduce il concetto moralistico di costume: deterioramento, decadimento, il degrado urbano, il degrado ecologico, il degrado dei costumi.
Poi un cartaceo, il De Agostini del 1990, dove degrado, degradarsi e degradazione, abbracciano, oltre ai precedenti, anche ambiti per così dire “spirituali”, assumendo la funzione di giudizio morale: disonorarsi, avvilirsi, umiliarsi, compiere azioni ignobili, perdere la propria dignità, vivere in uno stato di abiezione.
Esiste, infine, un sentire comune che comprende tutto quanto esposto dai vari dizionari ma privilegia alcuni usi e sensi rispetto ad altri. Per capirsi, il degrado delle coste e il degrado ecologico sono forme lessicali poco adoperate, vaghe e confuse, mentre hanno un immediato e potente potere di significazione locuzioni quali “una vita nel degrado”, “un lavoro degradante”, “degli atti degradanti”, “un ambiente (sociale) degradato”. Intendo dire che il degrado delle cose – naturale, ovvero entropico – non coinvolge, non richiama un vissuto, non muove l’immaginazione quanto il degrado umano, a sua volta riferibile all’individuo – gli atti degradanti di una persona -, o al collettivo – il degrado della società, di una classe, di un popolo. Nel primo caso si dà un giudizio morale, nel secondo l’accento è sulla trasformazione, transizione “da→a” intesa come peggioramento. È pur vero che un certo grado (non de-grado) di moralismo c’è anche nella seconda accezione, quando si chiama in causa l’idea di peggioramento, tuttavia l’indagine su atti collettivi, per sua natura e prassi, ha sempre un valore di scientificità, o di distacco, maggiore dello sguardo gettato sul comportamento singolo.
Che io ricordi, degrado è un termine utilizzato con moderazione in Petrolio, e d’altronde mi sarei stupito del contrario: il moralismo giudicante di Pasolini, che non è certo assente, si tiene lontano da un linguaggio troppo compromesso con i valori della borghesia cattolica. Eppure, in questo articolo, mostrerò come le due accezioni di degrado sopra individuate e definite – il degrado di un individuo e il degrado di un gruppo sociale – siano state dall’autore isolate e meticolosamente descritte, e rivelino una complementarità utile a gettare luce sulla struttura simbolica che ha mosso l’immaginario creativo pasoliniano nella scrittura del suo ultimo (incompiuto) romanzo.
* * *
«Ma per quanto brutto e ripugnante sia il Merda, con quegli spilocchi dietro il collo e alle basette, quei dentini gialli da sorca, quella faccia unta piena di cigolini che sembrano cacate di mosche, e quell’espressione la cui sufficienza è piena d’odio contro tutto e tutti benché non [disgiunto] da un’ansia [(ben nascosta)] con la quale egli va mendicando l’attenzione – i suoi ‘pari’ e ‘coetanei’ che sono ‘esposti’ nella luce vermiglia di Via XXX XXX sono ancora più brutti e ripugnanti.» (Appunto 71d)
Comincio con il degrado inteso come trasformazione e peggioramento collettivo. Circa 60 pagine dell’edizione Einaudi 1992 sono la narrazione dettagliata di una allucinazione – ma potremmo anche chiamarla visione mistica – che coglie il protagonista Carlo Valletti mentre una sera ascolta storie futili narrate da vaghi conoscenti sotto gli archi del Colosseo. La visione di Valletti ha come protagonista un giovane di circa venticinque anni chiamato Il Merda, il quale, abbracciato alla sua ragazza Cinzia, percorre Via di Torpignattara partendo dall’incrocio con Via Casilina in direzione di Via Tuscolana. Il lungo tragitto della passeggiata è scandito da tanti piccoli incroci con traverse laterali e a ognuno di questi la visione cambia mostrando nuovi dettagli, puntualmente narrati da Pasolini nell’arco complessivo di 29 appunti icastici, feroci, lucidi, visionari e grotteschi, strutturati secondo un modello “infernale” diviso in 15 gironi e 5 bolge. Il Merda è un perfetto rappresentante dei giovani delle periferie romane del tempo di Carlo Valletti e, fedele al suo soprannome, è descritto come un concentrato di iperbolica bruttezza e repellenza. L’occhio della visione segue la camminata del Merda e di Cinzia come una telecamera a campo largo, dando modo a Pasolini di descrivere, oltre ai due protagonisti, il quartiere di Torpignattara e i suoi abitanti, ritratti come travolti e trasfigurati dal conformismo consumistico piccolo-borghese dei ’60 e ’70. Ma la visione non si limita a mostrare la quotidianità coeva al Valletti: in trasparenza ad essa, infatti, illuminata con colori sbiaditi tra il grigio e il giallo, è possibile vedere anche i medesimi luoghi, strade, incroci, abitanti, con una sfasatura temporale di sette anni prima. Lo stesso sguardo sinottico, quindi, permette il confronto – impietoso – tra il prima e il dopo, palesa il peggioramento di un popolo, ovvero il suo degrado.
«Ebbene tutti costoro – che non dimentichiamolo, sono brutti e ripugnanti […] – emanano un odore tutto uguale, di barbiere e di corpo lavato male.
[…] È l’odore dell’impiegato fascista o dell’avvocato clericale: del bottegaio che esce sbarbato, fresco, abbronzato dal bagno; del capo d’azienda giovane e efficiente che adopera dell’acqua di colonia francese.
Questo odore è anche l’odore dei sessi: che, o sono lavati male – e quindi il sapone, mescolato all’urina, rende l’odore dell’urina un fetore; oppure il talco mescolato alla ‘caciotta’, rende l’odore della caciotta, per quel poco che XXX, asfissiante, Se invece sono lavati bene, il loro asettico non odorare di nulla, rende quei sessi, schifosamente, della povera carne, dei deboli ciondolanti organi anatomici.» (Appunto 71z)
I 29 appunti dedicati alla visione del Merda, oltre a essere tra i momenti letterari più alti e coinvolgenti di Petrolio, sono l’occasione per il manifestarsi del Pasolini sociologo, quello già apparso negli Scritti Corsari, che coglie la trasformazione in atto di quelle fasce della società italiana che un tempo si sarebbero definite classe operaia o proletarie, verso l’omologazione piccolo-borghese, attratte dalle sirene del benessere individuale, dell’edonismo, del consumo, del successo. Permettono l’accurata descrizione, quasi etnografica, del proletariato e sottoproletariato romano che viveva nelle periferie sud-est della capitale nei ’60 e ’70, una descrizione malinconica (la malinconia dell’antropologo che osserva mondi scomparire) ma anche furente per quella che Pasolini definisce distruzione di identità culturale, genocidio culturale da parte del potere capitalistico che tramite l’arma del consumismo e della televisione e della scuola pubblica omologa tutti all’ordine borghese post-fascista. Ed ecco che in pochi anni la «gente bellissima: donne grasse e scarmigliate con vestaglie nere e sporche […] vecchi con facce assatanate […] delinquenti ubriaconi [e poi] pipinare di ragazzini mezzi nudi, con le pance fuori, tutti mocciolosi» (Appunto 71c) viene sostituita da giovani «brutti e ripugnanti, divorati da una degradante ansia interclassista (con quelle loro borsette da puttane); sbiancati da una nevrosi che gli fa venire la bava alla bocca e gliela storce lividamente; brutalmente pronti a rinnegare tutto ciò che sono stati loro stessi o i loro fratelli» (Appunto 71u), gente insomma che «non aveva più la purezza della povertà […] non creava più il proprio modello umano […] non opponeva più la sua cultura a quella dei padroni» (Appunto 124).
La condanna pasoliniana di tale degrado è senza appello: «Ecco là gli antichi dritti e bulli di Torpignattara, che considerano un vanto la loro magrezza, la loro finezza, i loro atteggiamento delicati, lo stare con la spalluccia un po’ alta e il fianco in fuori, il fare con le mani gesti un po’ cascanti e [xxx]. I loro fratelli maggiori – i cui corpi erano stati lì, forti, poveri e violenti, solo pochi anni prima – se li sarebbero tutti inculati dal primo all’ultimo, o gli avrebbero dato fuoco. Ma probabilmente non avrebbero creduto ai loro occhi e li avrebbero presi per allucinazioni.» (Appunto 71v).
* * *
«Era un riccetto. I suoi capelli erano ricci ricci, ma lui, forse vergognandosene, se li era fatti tagliare corti, e se li pettinava con una forte e dritta riga da una parte. Sotto quei riccetti fitti, che formavano sulla fronte un ciuffo abbastanza [spavaldo], anche se così ben potato, la faccia era una onesta faccia di garzone; allegro di carattere e serio di propositi. «Che c’è?» chiese sorridendo. E guardava interrogativo Carlo che a sua volta guardava come XXX quel suo gonfiore sotto i calzoni. Era un gonfiore potente, di cui, al solito, Fausto un po’ si vergognava perché denunciava la sua ingenuità e la sua forzata castità di ragazzo: oltre che la sua deplorevole debolezza a essere così eccitato alla prima occasione. Doveva essere fin da principio, fin da quando erano entrati in quel pratone, che egli si teneva dentro i suoi umili calzoni di tela leggera, quel gonfiore. Che aveva qualcosa di bestiale e, appunto, osceno. Fausto infatti non era tanto alto di statura: e quel bastone che gli urgeva contro i calzoni – adesso che, sbottonati, avevano un po’ allentato la stretta – fin quasi a volerli spaccare, aveva qualcosa di eccessivo e di [priapesco].» (Appunto 55).
Restiamo nella zona di Via Casilina e da Torpignattara ci spostiamo nei pressi di un imprecisato pratone dove si svolge una delle scene più conosciute e discusse di Petrolio, appunto il Pratone della Casilina. Tratto del Pratone in merito alla seconda tipologia di degrado che voglio evidenziare nel testo pasoliniano, quello che sopra ho definito individuale e che ho legato, nel suo essere messo in luce, ovvero svelato, a un intento moralistico. Chiarisco – anzi: ripeto – che il moralismo potenziale della vicenda del Pratone non è minimamente agitato né evocato da Pasolini che invece descrive gli atti di quel capitolo con una empatia rara, profonda e per nulla giudicante. Il moralismo presente nel concetto di degrado, semmai, è tutto mio, e non perché io sia un Savonarola censore di comportamenti altrui, tutt’altro, ma perché osservo e significo in base a un sentire comune che successivamente posso anche discutere, criticare, rivoltare e rinnegare, ma che di primo acchito mi orienta nel mondo condiviso con gli altri. Cosa dunque accade di evidentemente degradante in questo pratone notturno rischiarato dalla luna e «riempito da un unico profondo odore, quello del finocchio selvatico» (Appunto 55)? Cosa, che il sentire comune, da me chiamato in causa, non potrebbe altrimenti definire che degradante?
«Ben presto il cazzo si gonfiò, si protese. Forse non era più grande di quello di Sandro o di Sergio, ma pareva il doppio. La sua forma dritta, piena di piccoli nodi di vene ma compatta, intensa, fino alla glande scoperta a metà, e odorosa: finalmente odorosa sia dell’urina, il cui zampillo aveva appena finito di sgorgare sul prato, sia di seme rappreso: o forse no, Erminio non era il tipo da masturbarsi ,e non doveva neanche aver [scopato] da poco, tanta era la violenza e il gonfiore del suo membro: forse era l’odore del seme contenuto dentro; ed (…) ad esso si mescolava un odore [di sesso], caldo, intenso, quasi profumato, che si accentuava nei testicoli , forti e tesi dentro la pelle pelosa. Era il pelo stesso che profumava. Era il profumo del sesso di un uomo molto [forte e sano], il cui cazzo è talmente virile da aver perso ogni ricordo della sua tenerezza infantile. Era così che doveva diventare: enorme, potete, caldo e odoroso.» (Appunto 55)
Il protagonista, Carlo Valletti, un ingegnere dirigente di alta fascia dell’ENI, uomo coltissimo, di famiglia benestante e borghese seppur di origine contadina, solidamente ancorato ai valori della cultura cattolico-popolare e antifascista, paga con moneta sonante una ventina di sconosciuti adolescenti, o poco più, che stanno passando la serata in questo prato urbano fatto di erba secca, terriccio polveroso, immondizia e cardi spinosi; li paga per praticare a tutti loro sesso orale, e per farsi sodomizzare lì, in quello stesso prato.
Circa 30 pagine di minuziosa descrizione di quei ragazzi, dei loro corpi, visi, odori, del loro sesso e del suo farsi oggetto del loro possesso. Una degradazione che non può essere letta altrimenti che come atto di ribellione, un deliberato oltraggio a tutti i valori borghesi che il Valletti-Pasolini indossa ogni dì come un’elegante accollata cravatta in una giornata di metà agosto e che la sera, finalmente, può strapparsi di dosso gettandola a terra. Ma non si tratta dell’oltraggio rivoluzionario dei ’60 illuminato dal “sol dell’avvenir”, né di quello libertario della cultura psichedelica e della Summer of Love: è un oltraggio malinconico e disilluso, nichilista, oscuro e demoniaco, un demoniaco che però nulla spartisce con la religione:
«non si trattava affatto di Demoni appartenenti a un Inferno dove si scontano condanne, ma semplicemente appartenenti agli Inferi, là dove si finisce tutti. Insomma, poveri Dei, che se ne andavano in giro lasciando dietro a sé il loro odore di cani, astuti e rozzi […]. Senza però né lutto né dolore: poiché nell’essere funebre consisteva l’odorosa, silente, bianca, e perdutamente quieta e felice, forma della città notturna, dei prati, del cielo. Naturalmente gli Dei degli Inferi, andandosene in giro in quella notte senza umidità […] erano soprattutto attratti da quel gruppo di loro simili che se ne stava in cima a un montarozzo del pratone: si erano andati evidentemente a mescolare fra loro, era chiaro, come Spiriti o Geni protettori, divini, ma nel tempo stesso umili, soggetti e fedeli come cani.» (Appunto 55).
* * *
«Carlo non aveva [ancora] capito quale legame intimo e supremo ci fosse tra povertà e corpo, e come il corpo ne fosse avvantaggiato, preservato com’era, così, nella sua “pasta” popolare che era salute, innocenza, barbarie, delinquenza: tutto fuorché senso di colpa, banalità e volgarità.» (Appunto 43a).
Dove, infine, possiamo far incontrare e ricomporre i due momenti di degrado? Come armonizzare il Pasolini analitico che attraverso il personaggio del Merda registra la scomparsa di un popolo e di una cultura col Valletti – alter ego di Pasolini – che nel Pratone della Casilina si lascia travolgere dalla passione e dalla possessione? Il corpo è la risposta, il terreno dell’incontro e della ricomposizione del senso. Le identità culturali che nell’analisi pasoliniana si trasformano, e nel trasformarsi si degradano, si manifestano attraverso i segni del corpo, gli sguardi, le espressioni, la gestualità, la camminata, la postura. Nel corpo si inscrivono le identità, i valori, l’immaginario di un popolo, e in tutta l’opera di Pasolini, letteraria quanto cinematografica, il corpo è il significante supremo.
Così come la passione ai limiti, o oltre i limiti, del grottesco, che travolge Valletti, non cela forse una disperata – fisica – ricerca di una società che non c’è più, la società del proletariato urbano ormai massificata negli stili di vita piccolo-borghesi? Quella di Valletti è una passione per visi e corpi che portano inconsapevolmente (senza averne ormai coscienza) residui di nobili appartenenze operaie e contadine, corpi di emigranti, corpi di “malandrini” semianalfabeti; è una passione avida per le proprie radici storiche e sociali; una passione disperata per un mondo che scompare perché ha barattato la propria dignità, ha perso, è stato ingannato. Una passione che è anche un patire, e un patire che è anche uno scontare. Cosa? Il senso di colpa di essere passato, lui per primo, dall’altra parte, dalla parte di chi attua il possesso («Il Possesso è un Male, anche per definizione, è il Male: quindi l’essere posseduti è ciò che è più lontano dal Male, o meglio, è l’unica esperienza possibile del Bene…» Appunto 65), dalla parte dei borghesi benestanti e di successo, di esser l’avanguardia di un’odiosa transizione sociale tendente al degrado culturale.
«I veri fascisti erano ora in realtà gli antifascisti al potere. Il potente era Carlo, non quei piangenti bambini stupidi che non conoscevano l’origine del loro dolore. […] Erano dei piccoli borghesi senza destino, messi ai margini della storia del mondo, nel momento stesso in cui venivano omologati a tutti gli altri.» (Appunto 126)